della Professoressa Francesca Peruzzotti
«La scuola italiana è il regno della menzogna e finché resterà tale non potrà che peggiorare». Questo l’incipit di un articolo di Ernesto Galli della Loggia, all’origine di svariate reazioni, ancor prima che per le posizioni esposte, per la brutalità del linguaggio impiegato per esprimerle («mito dell’inclusione», allievi «cosiddetti normali» contrapposti a quelli disabili).
Legittimi il fastidio, l’istintivo rifiuto e lo sdegno provocati da quelle parole, probabilmente accostate ad arte proprio per favorire una polemica fatua, adatta solo per ostacolare – una volta ancora – il tempo del pensiero e dell’impegno. Per dichiararne l’insensatezza è però necessario assumere una posizione differente, forse possibile solo rifiutando di lasciarsi impigliare nella vischiosità di quel ragionamento (in realtà assai carente sul piano delle argomentazioni).
Quando è a tema l’inclusione non è efficace rispondere limitandosi a proclamare buone intenzioni, né può bastare l’elenco ingenuo di principi; neppure la proposta di realizzazioni esemplari è risolutiva. Piuttosto, pare costruttivo intendere quell’articolo come un’occasione, propizia perché ciascuno si lasci interpellare e manifesti nell’operare consueto alternative possibili.
Galli della Loggia costruisce la sua provocazione riferendosi alla questione decisiva della verità, perdipiù declinandola nel delicato ambito della vulnerabilità cognitiva e sociale, lasciando intendere che inclusione e custodia delle differenze non sono possibilità reali, vanno dunque accantonate per evitare la menzogna. La verità, tuttavia, non è definibile a monte rispetto all’esperienza: essa non si esaurisce nella mera enunciazione di principi, né nella loro presenza formale in leggi, documenti e protocolli. Per natura propria, quando si riferisce all’esistenza umana, la verità non è dicibile una volta per tutte. Nessuno può affermare di averla raggiunta compiutamente: proprio proclamandola la negherebbe, limitando la definizione di sé a una misura predefinita, che pone tra parentesi desideri, ideali e possibilità che si danno solo al di là del compimento puntuale.
La scuola, fatta di viventi, si nutre proprio di quella forma della verità, fondata sulla ricerca piuttosto che sull’anticipazione di sicurezze. Per questo non si tratta affatto di un’impresa solitaria o riservata a pochi, ma corrisponde alla possibilità di configurare la propria identità grazie agli imprevisti e alle novità ricavati dall’incontro tra le differenze e dalla scoperta del proprio limite. Quella pratica è fondamentale perché apprendimento ed educazione si realizzino, mentre sarebbe contraddetta creando ambienti nei quali il confronto con le diversità e l’esperienza della fallibilità fossero impediti a priori.
Evitare la menzogna è quindi possibile, ciò accade quando ci si mantiene fedeli a un compimento che è ancora di là da venire, ma non per questo precluso, custodendo quella forma di verità che si realizza nel cammino della ricerca. Ciò non significa cedevolezza in favore di alibi o soluzioni a buon mercato: fare la verità trova concretezza se la realtà non è edulcorata, quando si evita di tacere le difficoltà e impegno e fatica sono considerati fondamentali. Delineare con onestà i limiti è infatti preludio alla consapevolezza delle risorse, come accade quando non ci si accontenta di quanto si conosce già, di sé e del mondo. Compito per tutti, nessuno escluso.

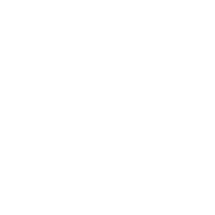


Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!