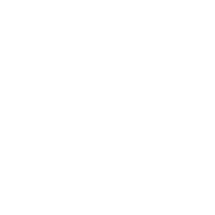di Anna Tedesi
“Il mito dell’inclusione nella scuola italiana” è il titolo del breve commento che lo storico Ernesto Galli della Loggia ha scritto in margine ad una breve recensione per il Corriere della sera.
In poche righe accusatorie e calunniose è stato racchiuso un tema complesso quale l’inclusione all’interno delle aule scolastiche italiane. In seguito ad una lettura veloce e superficiale è facile essere persuasi dalle parole convincenti e magnetiche; purtroppo però dietro il tono di critica sono celate accuse infondate e argomentazioni fallaci.
Galli della Loggia si appella alla verità, celata e occultata, che il sistema scolastico tenta di nascondere: i risultati pessimi ottenuti dalla tentata inclusività.
Negli anni ’90 ha inizio la rivoluzione educativa e pedagogica che ha come valore fondante la diversità come possibilità di crescita e maturazione personale. Dalla distinzione censitaria all’omogeneità del giorno d’oggi sono stati fatti grandi passi avanti, il percorso non è ancora terminato e c’è un grande raggio di miglioramento che ci attende, ma è essenziale riconoscere la positiva stratificazione e il complesso percorso rivoluzionario che il sistema scolastico ha compiuto.
Caso eclatante per lo storico sono le aule italiane dove “convivono regolarmente, accanto ad allievi cosiddetti normali, anche ragazzi disabili gravi con il loro insegnante personale di sostegno, poi ragazzi coi Bes (…) e infine, sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spiccicare una parola d’italiano”: con termini veementi e accusatori cerca di distorcere le condizioni attuali.
Quel che appella con tono dispregiativo essere “l’unico caso al mondo” è in realtà progressivo e indicativo della rivoluzione pedagogica.
Quel che Galli della Loggia non ha considerato e analizzato è la trasformazione che l’ambiente educativo ha subito negli anni: non si può infatti parlare di inclusività in quanto inserimento di alunni con disabilità, senza coinvolgere la collaborazione per favorire l’intera comunità scolastica, non solamente l’alunno con bisogni educativi speciali.
Un ulteriore punto di critica che dimostra l’instabilità e l’arretratezza del ragionamento dello storico è l’osservazione puntigliosa che ha voluto inserire in un discorso oggettivo; “poi ragazzi con i Bes (Bisogni educativi speciali: dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d’occhio anche per insistenza delle famiglie)”. Negli anni in cui Galli della Loggia era coinvolto negli studi primari e secondari, ragazzi con DSA o Bes non erano tenuti in considerazione: se gli studenti avevano difficoltà nello studio era a causa del loro mancato impegno, questa considerazione ha segnato per molto tempo la mentalità di maestri e professori e solo negli ultimi anni si è raggiunto una maggior sensibilizzazione.
Il potenziamento della cultura dell’inclusione è stato profondamente segnato dalla rivoluzione culturale che l’istituzione scolastica italiana ha affrontato: strumenti di intervento per gli alunni con Bes e la creazione e organizzazioni di criteri didattici inclusivi per tutti gli studenti che presentano difficoltà per cause culturali o socio-ambientali. Quindi il numero in crescita di ragazzi DSA o Bes non è certamente dovuto ad un’insistenza da parte dei genitori, ma dalla maggior sensibilizzazione e conoscenze da parte di studiosi e specialisti.
La consapevolezza delle problematiche degli alunni e il miglioramento degli ambienti scolastici per favorire l’inclusione nel corso degli anni hanno subito grandi cambiamenti, anche rivoluzionari, purtroppo però non ha coinvolto tutte le scuole d’Italia. Difatti ci sono numerosi istituti dove la diversità non viene accettata: questo comportamento è rappresentativo per evidenziare la limitatezza dei professori che ci lavorano. Ma gli aspetti ancora oscurantisti devono stimolare i futuri potenziamenti e sviluppi pedagogici, con professori pienamente sensibilizzati riguardo i bisogni degli studenti e metodi educativi e dell’apprendimento che siano modulabili a seconda delle difficoltà dell’apprendimento.